Crescita a quale costo? La finanza che non porta sviluppo
24 MARZO 2009
Relatori: Andrea Baranes (Campagna per la Riforma della Banca Mondiale/ATTAC Italia);
Elena Gerebizza (Campagna per la Riforma della Banca Mondiale);
Marco Bersani (ATTAC Italia).
Ci incontriamo oggi per la seconda volta nell’ambito del ciclo di seminari organizzati dai gruppi romani di Mani Tese e ATTAC sul tema della risorsa “terra”.
Il primo incontro è stato dedicato alla terra come fattore di produzione: nella ricerca delle cause della crisi alimentare globale si è giunti al confronto tra due modelli agricoli profondamente differenti e incompatibili, l’agribusiness e l’agricoltura orientata all’export da una parte e l’agricoltura di sussistenza in un’ottica di raggiungimento della sovranità alimentare dall’altra.
L’utilizzo della terra da parte degli esseri umani, quindi, lungi dall’essere qualcosa di “naturale”, è sempre un atto intrinsecamente “politico” e presuppone la scelta, anche se a volte obbligata a volte quasi inconsapevole, di un modello di sviluppo preciso.
In particolare, Andrea Baranes decide di affrontare una questione assolutamente centrale: la finanziarizzazione dell’economia, che caratterizza il modello dominante attualmente. A partire dagli anni ’70, infatti, è diventato sempre più profittevole investire nella finanza piuttosto che nell’economia reale, e si è avviato un processo di spostamento dei redditi dal lavoro al capitale, che in Italia ad esempio è stato particolarmente evidente (8 punti percentuali di PIL, circa 120 miliardi, dagli inizi degli anni ’90 ad oggi). Ciò fa sì che si ponga un lampante problema di ingiustizia redistributiva: se “i soldi si fanno con i soldi”, chi è ricco diventa sempre più ricco mentre chi è povero affonda sempre di più nelle pastoie della povertà. La falsa soluzione è allora, per assurdo, il ricorso all’indebitamento: l’esplosione della finanza diventa così al tempo stesso causa e conseguenza della crisi. Mentre in un Paese come l’Italia ad aumentare è stato soprattutto il debito pubblico, negli Stati Uniti il debito è principalmente dei privati, delle famiglie. Un debito, quello USA, pari ad una volta e mezzo il PIL, che tradotto significa “spendere oggi quello che guadagnerò tra un anno e mezzo”, ovvero vivere ben al di sopra delle proprie possibilità. La crisi dei mutui subprime, concessi ai clienti definiti in gergo finanziario NINJA (No Income No Job No Assets) incapaci di fornire qualsivoglia garanzia, rappresenta quindi la punta dell’iceberg, la degenerazione di un sistema profondamente malato, che già porta in sé i germi della crisi.
La finanza oltre ad espandersi verticalmente è cresciuta orizzontalmente, fino ad invadere e pervadere il campo dei diritti e dei beni comuni: pensiamo all’acqua, ai Fondi Pensioni in mano ai mercati, alle società finanziarie specializzate che stanno iniziando, soprattutto in Asia, ad acquistare il diritto a produrre un determinato prodotto agricolo, salvo poi riservarsi la possibilità di non produrre in base all’andamento dei mercati, o nella volontà di influenzare i mercati stessi.
Abbiamo iniziato parlando di finanziariazzazione dell’economia ma appare chiaro che questo sia solo una parte del problema: a subire il processo di finanziarizzazione è, oggi, la vita stessa.
Da un certo punto di vista, la crisi attuale è così profonda perché è difficile oggi tracciare confini netti tra l’economia reale e l’economia finanziaria. Lo stesso fenomeno dello spostamento dei redditi dal lavoro al capitale trova la sua causa ultima nel ricorso all’indebitamento da parte della popolazione: se il salario, diretto o indiretto (cioè i servizi), non è più sufficiente ecco allora apparire i fondi pensione e la possibilità di indebitarsi per qualsiasi cosa. E’ nell’economia reale, quindi, che nascono le premesse per la finanziarizzazione dell’economia.
E’ questa la posizione di Marco Bersani, che mette in discussione radicale il modello neo-liberista che è all’origine della crisi. Dobbiamo sovvertire lo spazio-tempo liberista, in cui la dimensione spaziale è illimitata (tutto il mondo è mercato) e l’orizzonte temporale è rappresentato dall’indice di borsa di domani, per ricentrarci sullo spazio locale ma nei tempi necessariamente lunghi della tutela dei beni comuni. Ed eccoci quindi arrivati al cuore del problema: il mondo oggi è diviso in due, da una parte i poveri, che sono talmente poveri da non essere in grado di consumare, e dall’altra i ricchi, il cui mercato è però in via di saturazione. La nuova frontiera del liberismo è quindi la mercificazione dei beni comuni: strategia di mercato macabramente geniale e di sicuro successo, dal momento che dei beni comuni abbiamo tutti bisogno per vivere e non occorre “convincerci” a consumare e comprare attraverso dispendiose campagne pubblicitarie. La nostra vita è diventata il mercato. Eppure proprio la profondità della crisi può tradursi in un’opportunità di cambiamento, se attraverso un processo partecipato e condiviso concentriamo la riflessione sui beni comuni, innanzitutto quelli naturali, riconducibili ai quattro elementi di memoria pre-socratica: aria, acqua, terra e fuoco, ovvero in termini moderni aria, acqua, territorio/mobilità ed energia. I beni comuni naturali e sociali (salute, abitazione, istruzione, previdenza e sicurezza sociale, comunicazione, conoscenza, cultura) devono essere sottratti al mercato, andando oltre il binomio proprietà pubblica/proprietà privata e introducendo la fondamentale categoria di proprietà sociale. Ciò significa lavorare insieme per costruire un modello diverso in cui la gestione dei beni comuni sia affidata al pubblico, ma la loro proprietà resti di tutti. Anche se viviamo uno vicino all’altro, in una grande città come in un piccolo paese, senza beni comuni siamo individui singoli e separati. I beni comuni sono il collante stesso della società, sono ciò che ci rende una comunità. Nel passaggio quindi da una fase di consumo critico ad una fase di produzione critica, ancora una volta la questione fondo è di natura politica: una questione di partecipazione, di condivisione, in ultima analisi, di democrazia.
A questo punto sorge quasi spontaneo chiedersi quale sia il ruolo giocato in questo contesto dalla comunità internazionale e dalle Istituzioni Finanziarie Internazionali in particolare.
Elena Gerebizza si concentra soprattutto sulla Banca Mondiale (BM), la principale banca multilaterale del mondo, con un budget di circa 40 miliardi di dollari. La BM è un’istituzione pubblica, al cui tavolo siedono quindi i governi dei paesi membri, che concede prestiti tanto al settore pubblico (ovvero ai governi dei paesi poveri o emergenti) quanto al settore privato (grandi corporations multinazionali soprattutto). Nel primo caso i tassi d’interesse applicati sono molto bassi, a volte i prestiti sono a fondo perduto, e proprio per questo storicamente i paesi più poveri in assoluto, come quelli africani, sono sempre stati i più dipendenti dall’aiuto della banca.
Nella realtà dei fatti, il ruolo della BM va ben al di là della concessione di prestiti ai governi dei paesi in difficoltà. Pensiamo ad esempio al ruolo di “catalizzatore degli investimenti” che la BM inevitabilmente svolge: concedendo un prestito ad un paese, la banca lancia un segnale positivo di fiducia agli altri prestatori (pubblici o privati) riguardo all’affidabilità di quel paese. Da non sottovalutare è infine il ruolo di policy advisor che la banca ha sempre svolto e continua a svolgere: una funzione di “consulenza” ai governi riguardo alle politiche da adottare per innescare lo sviluppo.
Nonostante la banca sia un’istituzione enorme, che può contare su migliaia di dipendenti, alla prova dei fatti la scelta finale è sempre caduta sulla ricetta unica, prefabbricata e dogmatica secondo cui la crescita porta sviluppo (secondo la teoria del trickle down, ovvero dello “sgocciolamento”: i benefici della crescita, prima o poi, raggiungeranno tutte le fasce della popolazione). Ciò ha significato trascurare la questione della distribuzione del reddito, con la conseguenza che i paesi che hanno seguito pedissequamente le prescrizioni della banca sono oggi i più vulnerabili, caratterizzati da una sperequazione dei redditi (ovvero la forbice tra ricchi e poveri) in costante aumento. Il paradigma di sviluppo fatto proprio dalla BM negli ultimi 25 anni, inoltre, è basato sulle infrastrutture, soprattutto nel settore energetico (costruzione di oleodotti, gasdotti, grandi dighe): un modello orientato all’export e foriero di impatti negativi sul territorio, tanto a livello ambientale quanto sociale. Da sempre la banca considera il coinvolgimento del settore privato come un pilastro imprescindibile per lo sviluppo dei paesi del Sud del mondo, continuando a sostenere lo strumento delle partnership pubblico-privato, che si sono invece rivelate un fallimento tanto nel Nord quanto nel Sud, ad esempio nella gestione di un bene comune come l’acqua o nella fornitura di elettricità. I soggetti privati non avranno interesse ad effettuare investimenti non remunerativi anche se utili alla comunità, come la costruzione di nuove infrastrutture o il collegamento alla rete di famiglie e popolazioni che vivono isolate, lontano dai centri abitati.
A tutto ciò si aggiunge il ruolo di primo piano che la banca si sta ritagliando nella lotta al cambiamento climatico: il G20 di Londra probabilmente si concluderà con un impegno dei 20 grandi della terra ad aumentare la propria quota per la banca, nell’obiettivo primario di affrontare in questa sede la questione “clima”, nonostante la banca sia il principale finanziatore di mega-progetti nel settore estrattivo e delle grandi dighe (considerati come investimenti nelle energie rinnovabili). La BM gestisce dei fondi fiduciari, finanziati dai grandi del pianeta, il cui obiettivo dichiarato è tutelare i deboli paesi del Sud dal punto di vista ambientale: in realtà, gli impatti negativi di questa politica si stanno già rivelando in tutta la loro drammaticità. Nel mercato dei crediti di carbonio, ad esempio, rientrano anche le foreste: ciò significa che un paese può vendere parti di foresta a soggetti privati, il cui compito dovrebbe essere quello di salvaguardarle. Tuttavia, in questi territori spesso vivono comunità indigene, del tutto escluse dal processo decisionale e costrette ad abbandonare la propria terra. Tutto ciò, mentre in sede ONU procede a fatica il farraginoso processo per la creazione di un Fondo multilaterale specificatamente rivolto ad affrontare le questioni ambientali.
In conclusione, appare chiaro come non si possa prescindere oggi da una riforma radicale di questa istituzione, mettendone in discussione le politiche e il paradigma di sviluppo che ne è alla base. Forse, una soluzione possibile sarebbe far rientrare la banca nel suo mandato originario: una banca internazionale che fornisce prestiti ai paesi in difficoltà, e non uno strumento di imposizione di condizioni eminentemente politiche.
domenica 5 aprile 2009
Secondo incontro: CASCA IL MONDO...TUTTI GIU’ PER TERRA?
*Valentina*
Iscriviti a:
Comment Feed (RSS)



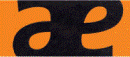





|